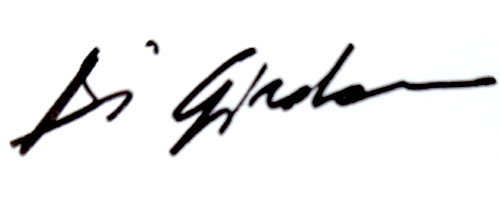Roberta Di Girolamo lavora in tenace appartatezza, in “polare ritrosia”, attorno a un’idea di luce: luce lontana, diaccia – ma capace di accensioni e temperature affocate, talora – e sottratta definitivamente alle finitezze del sensibile. Questo dice la bianchezza elaborante che cresce di stesura in stesura, e di dipinto in dipinto, cadenzata e come respirante nel contaminarsi di quei toni di terra e di sole. Luce che è luce d’anima, la sua, che scrive i flussi affettivi più intimamente risentiti, auscultati e scrutinati non per intimismo morboso, ma per dilucidare, di sé, il nucleo emotivo fondamentale. E’ un lavoro duro, concentrato. Di Girolamo lo affronta con gli strumenti linguistici d’una astrazione lirica che è, per lei, l’unica lingua possibile: perché nelle ore lunghe e come di trance nello studio l’artista non intende la tela come l’altro cui affidare lo scambio sensoriale e intellettuale, bensì la sa come il luogo proprio, il luogo cruciale in cui trovarsi, e riconoscersi, definitivamente. E’ un modo, dunque, non di fare pittura ma di essere pittura, totalmente inattuale rispetto allo stile e alle modalità, indifferente al tempo esteriore, calato irrevocabilmente in un soliloquio ansioso ancora di verità possibile, almeno intuita. Questo, anche, si avverte nel seriarsi dolcemente ossessivo delle opere, nelle quali si dipana una catena di situazioni emotive delle quali assaporare la sottigliezza, e insieme la plenitudine d’una identità fatta immagine. Sono, questi quadri, e si offrono a noi, come trame d’autentico, e pitture necessarie. Non di molte altre, oggi, si può dire altrettanto.
Flaminio Gualdoni