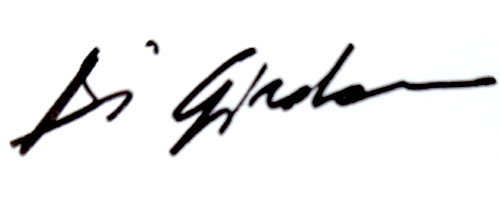L'oceano dell'indicibile
È Italo Calvino ad averci lasciato la definizione forse più intensa e suggestiva di “indicibile”: un'entità che ai suoi occhi si identificava con l'inconscio e che in esso risiedeva. «L'inconscio – scriveva Calvino – è l'oceano dell'indicibile, di tutto ciò che è stato espulso dalla terra del linguaggio, rimosso come risultato di un'antica proibizione”. L'“indicibile” sarebbe dunque, insieme, un luogo e uno stato; qualcosa che si pone in un territorio ìnfero, oscuro e difficilmente violabile, quale è, per definizione, il regno dell'inconscio. Con strumenti cognitivi ovviamente diversi da quelli della psicanalisi, ma con un'affinità sostanziale impressionante, allo stesso territorio oscuro fa riferimento anche il mito greco, che situa nell'Ade e nei suoi impronunciabili segreti il regno non-dicibile, identificandolo, poi, con il luogo da cui trae alimento la vita stessa.
Nel suo recente saggio “La ragazza indicibile”, dedicato al mito di Kore-Persefone1, il filosofo Giorgio Agamben identifica l'“indicibile” con i misteri eleusini, i più segreti ed elusivi fra i culti misterici dell'antica Grecia: la loro dottrina era infatti rigidamente negata ai più e poteva schiudersi, con diversi gradi di rivelazione, ai soli inziati. Più d'ogni altra era legata al silenzio, al non-detto, all'impossibilità di comunicare le sue verità attraverso i consueti canali del logos e della ragione. Unica via di accesso alla conoscenza dei misteri Eleusini era il sapere iniziatico del veggente; di chi, invasato dalla divinità, era in grado di connettersi per altre vie ai suoi segreti. Quel mito, che parlava del ciclo eterno della fertilità della terra (e quindi anche della rinascita della vita dopo la morte), si fondava sulla violenza dello stupro perpetrato da Ade, il dio degli Inferi, su Kore, la fanciulla rapita2. Un atto di violenza e di brutalità su un essere indifeso, dunque un gesto davvero indicibile, eppure posto a fondamento del ricorrere delle stagioni e del ciclico rigenerarsi della natura: qualcosa che in una civiltà agricola e pastorale quale era quella dell'antica Grecia stava alla radice della stessa sopravvivenza dell'umanità. Dunque, un atto indicibile se osservato con gli strumenti della ragione, non tale però per l'“occhio”, altro e segreto, della visione misterica, che sottometteva quella violenza altrimenti ingiustificabile ai bisogni superiori del perpetuarsi della vita.
È in un solco affine a questo, permeato di una violenza avvertita ma non rivelata, che si è posta Roberta di Girolamo nel nominare l'importante personale che la porta per la seconda volta (la prima fu nel 2007) a esporre il suo lavoro recente negli spazi di Cascina Roma, a San Donato Milanese, la città alle porte di Milano dove lei vive e lavora, ai bordi di un grande parco; quando non è a Roma o nella prediletta Isola d'Elba. Con quel titolo potente – L'Indicibile, appunto – Roberta di Girolamo ha voluto infatti evocare quel «sentimento di paura che si manifesta quando una cosa, una persona, un fatto, una situazione, sono avvertiti come familiari ed estranei allo stesso tempo, cagionando così angoscia e una dolorosa sensazione di confusione ed estraneità: indicibile – aggiunge – è tutto ciò che potrebbe restare segreto, nascosto, e che invece affiora in noi suscitando turbamento». Ma ha poi specificato ulteriormente il suo campo d'indagine, inoltrandosi deliberatamente nel terreno doloroso e più che mai attuale della «violenza nei rapporti interpersonali: un tema forte e taciuto, relegato a ombra dietro a un'apparenza dorata. Violenza fautrice d'angoscia, di sofferenza, di manipolazione».
Per esprimerlo, questo concetto sfuggente, anche lei ha eluso il logos, che è parola e ragione, per servirsi del linguaggio intenso ed eloquente della pittura. Che ha declinato in forme e modi anche molto diversi fra loro e spesso (almeno in apparenza) gioiosi per effetto delle vivide tonalità prescelte: rossi accesi e cangianti, gialli luminosi, bianchi abbaglianti, blu-verdi abissali, fino ad arrischiare la lucentezza dell'oro. Né certamente il nero, che pure è uno dei suoi colori prediletti, ha saputo spegnere la vitalità di queste cromie ardenti. Eppure, a dispetto di una tavolozza tanto gloriosa, perché di fronte a questi suoi dipinti si avverte una sensazione di inquietudine, di smarrimento?
Il fatto è che tutti i suoi dipinti, ma specialmente i più recenti, sono accomunati dal venir meno di ogni punto di riferimento, di ogni “bussola” d'orientamento, e quindi da un sentimento dell'illimite che induce nella coscienza dell'osservatore uno spaesamento perturbante e doloroso. Questa «ragazza artista», questa «ragazza intensa, dolce e acuta, forse un po' trasognata» come la definisce – a perfezione – Maurizio Cucchi nel testo che accompagna la personale milanese del 20083, questa ragazza sottile e (apparentemente) fragile non ha mostrato infatti paura nell'affrontare quei territori inquieti, nei quali, anzi, si avventura da sempre con la sicurezza di chi sa di avere una profondità di pensiero e di emozioni sufficiente per affrontarne i pericoli.
Allo stesso modo Roberta di Girolamo non ha alcun timore di porsi in «una posizione del tutto inattuale, in deliberato asincrono»4, come scrive Flaminio Gualdoni (il suo primo e più puntuale esegeta) nel catalogo di Luoghi subdoli, la mostra che si tenne nel 2007 in questa stessa sede. È evidente che dietro alla sua pittura c'è l'informale europeo degli anni Cinquanta del Novecento; c'è la pittura di Nicholas de Staël e di altri maestri che, come lui, depositavano sulla tela le loro emozioni. Informale sì ma europeo, ripetiamo: perché in tutti i suoi artisti, e in de Staël soprattutto, il movimento europeo mostra un controllo gestuale sconosciuto agli Action Painters e al tempo stesso un flusso di coscienza più mobile rispetto all'immota spiritualità di un Rothko e degli altri pittori del Colour Field Painting.
Se Roberta di Girolamo sceglie questa via apparentemente inattuale (sebbene qualcosa sia cambiato da quando ne scrisse Gualdoni nel 2007, e si assista da qualche tempo a una nuova apertura di credito verso quella corrente pittorica) è perché anche lei, come loro, intende principalmente la pittura come luogo in cui far confluire il flusso delle emozioni. Che si incarnano nei suoi dipinti in immagini inidentificabili e mai mimetiche ma evocative, quasi proiettive si vorrebbe dire, perché ognuno, come in un test di Roscharch, può rivestirle dei propri vissuti e delle proprie emozioni.
Ecco allora che i grandi dipinti recenti di formato orizzontale evocano distese acquee: non mari quieti però, ma stagni, acquitrini – tutte entità allarmanti nell'immaginario collettivo –, perché sono solcati verticalmente da linee che rinviano agli steli della vegetazione palustre, mentre i loro colori sono spesso avvampati da un (ipotetico) sole al tramonto, che ne vira la luce verso tonalità sanguigne. Questa descrizione “naturalistica” non deve però trarre in inganno, perché i dipinti di Roberta di Girolamo – lo dicevamo – non sono mai mimetici ma piuttosto evocativi, e sono al contempo costruzioni attente e sorvegliate di rapporti cromatici e formali, generatori di un assoluto equilibrio (esemplare il caso di La Foresta nera, 2009, con il suo intersecarsi di linee e di colature nere su bianco, composte in un reticolo che si rivela sorretto da un rigore potente).
L'elemento acqueo (che, non va dimenticato, è per Jung simbolo dell'inconscio) ricorre poi con anche maggiore evidenza nei bellissimi lavori recenti di formato quadrato: dipinti ad acrilico o a smalto, tutti del 2010, giocati su colature di colore (uno, non a caso, intitolato Parole liquide), che sembrano sprofondare l'occhio dell'osservatore in profondità vertiginose ora fisiche (Il Burrone, acceso dal bagliore dell'oro) ora allegoriche (Cuore sacro), mentre altri, come l'acrilico Early Morning, richiamano rugiade colanti su lastre di vetro. Effetti preziosi, questi ultimi, ottenuti con tecniche desuete come la velatura, alle quali Roberta di Girolamo non ha timore di affidarsi, e con accorgimenti antichi – come l'uso a lei caro di diluire i pigmenti a olio in puro olio d'oliva – che generano nei suoi dipinti effetti suggestivi di piani sovrapposti e di vertiginose profondità di campo. Allo stesso modo, nei suggestivi monocromi bianchi non esita a mischiare ad acrilici dall'aspetto gessoso granuli materici di sabbie e di altre sostanze, dando vita a un impasto corposo che stende poi a spatola, giocando con creste e avvallamenti di materia che rendono vivente e vibrante il candore della superficie.
Ma non meno felici sono le carte (in realtà veri, rifinitissimi dipinti), in cui si serve di pastelli a olio e talora anche di colori a olio molto diluiti, o di matite mischiate a oli, stesi su grandi carte preziose. Talvolta sono invece acquarelli dai toni bruni o chiarissimi, come nelle carte eseguite in un lungo viaggio australiano che portano in sé le tonalità bruciate delle terre centrali di quel continente. E con essi traccia quelli che lei stessa definisce i suoi «segni inquieti»: i segni dell'indicibile.
Ada Masoero